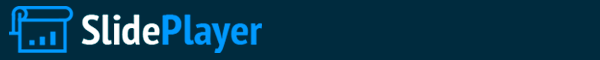
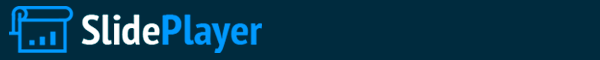
PARERE CONSULTIVO SULL’APPLICAZIONE EXTRATERRITORIALE DEGLI OBBLIGHI DI NON-REFOULEMENT DERIVANTI DALLA CONVENZIONE RELATIVA ALLO STATUS DEI RIFUGIATI DEL 1951 E DAL SUO PROTOCOLLO DEL 1967 Università degli studi di Firenze Francesco La Pia
IL PRINCIPIO DI NON-REFOULEMENT IN BASE AL DIRITTO INTERNAZIONALE DEI RIFUGIATI Obblighi di non-refoulement in base ai trattati internazionali sui rifugiati La Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati e il suo Protocollo del 1967 Il principio di non-refoulement è enunciato nell’art. 33 della Convenzione del 1951, vincolante anche gli Stati parte del Protocollo del 1967. L'art. 33(1) della Convenzione del 1951 dispone che: “Nessuno Stato contraente potrà espellere o respingere (“refouler”) - in nessun modo - un rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad una determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche”. La protezione dal refoulement così espressa dall’art. 33(1) si applica a chiunque soddisfi i criteri enunciati nella definizione di rifugiato contenuta nell’art. 1A(2) della Convenzione del 1951 e non rientri nell’ambito di una delle disposizioni di esclusione.
La natura della determinazione dello status di rifugiato è dichiarativa: una persona non diventa un rifugiato perché è stata riconosciuta come tale, ma è riconosciuta come tale proprio perché è un rifugiato. Il principio di non-refoulement si applica quindi non solo ai rifugiati riconosciuti, ma anche a coloro il cui status non è stato formalmente dichiarato. Ciò riveste particolare importanza per i richiedenti asilo. Poiché questi potrebbero essere rifugiati, costituisce un principio accettato di diritto internazionale dei rifugiati il fatto che essi non dovrebbero essere respinti o espulsi finché non si sia giunti a una decisione finale riguardo al loro status. Il principio di non-refoulement così come enunciato nell’art. 33(1) della Convenzione del 1951 non implica, come tale, il diritto di un individuo di ottenere l’asilo in un determinato Stato Il divieto di refoulement verso una situazione di pericolo di persecuzione in base al diritto internazionale dei rifugiati è applicabile a ogni forma di trasferimento forzato, compresi deportazione, espulsione, estradizione, trasferimento informale o “rendition” e non ammissione alla frontiera. Riferendosi all’art. 33(1) della Convenzione del 1951, l'UNHCR ritiene che si applichi non solo in relazione al ritorno nel paese d’origine o, nel caso di una persona apolide, nel paese di precedente residenza abituale, ma anche a qualsiasi altro luogo in cui una persona abbia motivo di temere minacce per la propria vita o libertà, in riferimento a una o più delle fattispecie elencate nella Convenzione del 1951, o dal quale egli o ella rischia di essere inviato verso un simile pericolo.
Eccezioni al principio di non-refoulement Eccezioni al principio di non-refoulement in base alla Convenzione del 1951 sono consentite solo nelle circostanze espressamente menzionate nell’art. 33(2), che dispone: “Il beneficio di detta disposizione [art. 33(1)] non potrà tuttavia essere invocato da un rifugiato per il quale vi siano gravi motivi per considerarlo un pericolo per la sicurezza dello Stato in cui si trova, oppure da un rifugiato il quale, essendo stato oggetto di una condanna già passata in giudicato per un crimine o un delitto particolarmente grave, rappresenti una minaccia per la comunità di detto Stato”. L’applicazione di questa disposizione richiede una determinazione su base individuale da parte del paese nel quale si trova il rifugiato.
Inderogabilita' del principio di non-refoulement Nel quadro delineato dalla Convenzione del 1951 e dal Protocollo del 1967, il principio di non-refoulement costituisce una componente essenziale ed inderogabile della protezione internazionale dei rifugiati. L’art. 42(1) della Convenzione del 1951 e l’art. VII(1) del Protocollo del 1967, indicano l’art. 33 come una delle disposizioni della Convenzione del 1951 cui non sono consentite riserve. Il carattere fondamentale e non derogabile del principio di non-refoulement è stato riaffermato anche in numerose conclusioni del Comitato Esecutivo dell’UNHCR a partire dal 1977. Anche l’Assemblea Generale ha invitato gli Stati a “rispettare il fondamentale principio del non-refoulement, che non è soggetto a deroga”. Il principio non è derogabile e si applica in tutte le circostanze, anche in un contesto di misure mirate a combattere il terrorismo e in periodi di conflitto armato.
Il non-refoulement dei rifugiati nel diritto internazionale consuetudinario L’UNHCR ritiene che il divieto di refoulement dei rifugiati, così come contenuto nell’art. 33 della Convenzione del 1951 e completato dagli obblighi di non-refoulement previsti dal diritto internazionale dei diritti umani, sia una norma di diritto internazionale consuetudinario (in quanto soddisfa i criteri di una coerente pratica da parte degli Stati e dell'opinio juris). Pertanto vincola tutti gli Stati, compresi quelli che non hanno aderito alla Convenzione del 1951 e/o al suo Protocollo del 1967. Nell’esperienza dell’UNHCR, gli Stati hanno abbondantemente indicato di accettare il principio di non- refoulement come vincolante, come dimostrato - inter alia - in numerose istanze nelle quali gli Stati hanno risposto alle rappresentanze dell’UNHCR fornendo spiegazioni o giustificazioni di casi di effettivi o presunti refoulement, in tal modo confermando implicitamente l’accettazione del principio.
Obblighi di non-refoulement nel diritto internazionale dei diritti umani L’art. 3 della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1984, proibisce il trasferimento di una persona in un paese dove vi siano fondati motivi di ritenere che egli o ella sarebbe in pericolo di subire tortura. Tra gli obblighi previsti dal Patto sui diritti civili e politici del 1966, così come interpretato dal Comitato Diritti Umani, sono compresi anche gli obblighi di non estradare, deportare, espellere o rimuovere in altro modo una persona dal loro territorio, verso luoghi in cui vi sia un rischio reale di danno irreparabile, quali quelli contemplati dagli artt. 6 [diritto alla vita] e 7 [diritto di essere libero da tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti] del Patto, siano essi il paese verso il quale il trasferimento sarà effettuato o qualsiasi altro paese in cui la persona possa essere successivamente trasferita. Il divieto di refoulement verso un rischio di gravi violazioni dei diritti umani, in particolare tortura e altre forme di maltrattamento, è sancito anche in trattati regionali sui diritti umani. (ex. Caso Soering vs UK).
Applicabilità extraterritoriale del principio di non-refoulement in base alla Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 In conformità con le norme pertinenti, come stabilito dalla Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, il significato di una disposizione contenuta in un trattato internazionale deve essere stabilito attraverso l’esame del significato comune dei termini impiegati, alla luce del contesto, dell’oggetto e dello scopo del trattato. Anche le successive pratiche degli Stati nell’applicazione del trattato, così come le norme di diritto internazionale rilevanti, devono essere tenute in considerazione al momento di interpretare un trattato. L’UNHCR è del parere che lo scopo, l’intento e il significato dell’art. 33(1) della Convenzione del 1951 sono univoci e stabiliscono un obbligo a non rinviare un rifugiato o un richiedente asilo in un paese dove egli o ella rischierebbe persecuzioni o altri gravi danni, Tale obbligo si applica ovunque lo Stato eserciti la sua giurisdizione, compreso alla frontiera, in mare aperto o sul territorio di un altro Stato.
Ambito ratione loci dell’art Ambito ratione loci dell’art. 33(1) della Convenzione del 1951: significato comune, contesto, oggetto e scopo della Convenzione del 1951 L’obbligo stabilito nell’art. 33(1) della Convenzione del 1951 è soggetto a restrizione geografica solo con riferimento al paese in cui un rifugiato non può essere inviato, non al paese dal quale egli o ella viene rinviato. L’applicabilità extraterritoriale dell’obbligo di non-refoulement ai sensi dell’art. 33(1) è chiara dallo stesso testo della disposizione, che enuncia una proibizione semplice: “Nessuno Stato contraente potrà espellere o respingere (“refouler”) - in nessun modo - un rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate…”. Il significato comune di “rinviare” comprende “mandare indietro” o “portare, inviare o rinviare in un posto precedente o adeguato”. La traduzione di “refouler” comprende parole come ‘respingere’, ‘repellere’, ‘portare indietro’. L'UNHCR ritiene che il significato comune dei termini “rinviare” e “respingere” (“refouler”) non sostiene alcuna interpretazione che avrebbe il risultato di restringere il suo ambito di applicazione all’interno del territorio dello Stato interessato, né vi è alcuna indicazione che tali termini fossero intesi dagli autori della Convenzione del 1951 per essere limitati in questa maniera.
È stata avanzata l’ipotesi che l’art 33(2) della Convenzione del 1951, che consente eccezioni al principio di non-refoulement solo con riferimento a un rifugiato che costituisca un pericolo per la sicurezza della comunità dello Stato nel quale si trova, implichi che l’ambito dell’art. 33(1) sia anche limitato alle persone che si trovano all’interno del territorio del paese ospitante. Tuttavia l’UNHCR ritiene che tale visione sia contraddetta dalla chiara terminologia impiegata negli artt. 33(1) e 33(2), che si riferiscono a questioni diverse, così come dal fatto che l’ambito territoriale di diverse altre disposizioni della Convenzione del 1951 sia stato reso esplicito. Inoltre, ogni interpretazione che definisce l’ambito dell’art. 33(1) della Convenzione del 1951 come non estendersi a misure in cui uno Stato, agendo fuori del proprio territorio, rinvia o trasferisce in altro modo rifugiati in un paese nel quale essi sono a rischio di persecuzione sarebbe fondamentalmente incoerente con l’oggetto e lo scopo umanitario della Convenzione del 1951 e del suo Protocollo del 1967. Un esame organico dei lavori preparatori conferma la predominanza dell’oggetto e delle finalità umanitarie della Convenzione e fornisce una significativa evidenza sul fatto che la disposizione sul non-refoulement contenuta nell’art. 33(1) era intesa a vietare ogni atto od omissione da parte di uno Stato contraente che avesse l’effetto di rinviare un rifugiato in territori nei quali egli o ella dovesse probabilmente affrontare persecuzione o pericolo per la vita o la libertà.
Applicabilità extraterritoriale dell’art Applicabilità extraterritoriale dell’art. 33(1) della Convenzione del 1951 pratica da parte degli Stati e norme di diritto internazionale rilevanti Nel determinare se gli obblighi di uno Stato sui diritti umani sussistono nei confronti di una determinata persona, il criterio decisivo non è se quella persona si trovi sul territorio nazionale di quello Stato, o all’interno di un territorio che sia de jure sotto il controllo sovrano dello Stato, quanto piuttosto se egli o ella sia o meno soggetto all’effettiva autorità di quello Stato. Nel suo Commentario Generale n. 31 sulla natura dell’obbligo generale imposto agli Stati parte del [ICCPR], il Comitato Diritti Umani ha affermato che “agli Stati è richiesto dall’art. 2(1) [dell’ICCPR] di rispettare e garantire i diritti del Patto a tutte le persone che potrebbero trovarsi all’interno del loro territorio o soggette alla loro giurisdizione. Ciò significa che uno Stato parte deve rispettare ed assicurare i diritti stabiliti nel Patto a chiunque si trovi sotto il potere di effettivo controllo da parte dello Stato parte, anche se non situato all’interno del territorio dello Stato parte”. Il Commentario Generale ribadisce una coerente giurisprudenza del Comitato Diritti Umani con il risultato che gli Stati “possono essere ritenuti responsabili per violazioni dei diritti contenuti nell’ICCPR che i suoi agenti commettono sul territorio di un altro Stato, sia con il consenso del Governo di quello Stato, sia in opposizione di esso” e che in determinate circostanze, “le persone possono rientrare nella competenza di uno Stato parte [dell’ICCPR] anche quando si trovano fuori del territorio di quello Stato”.
La Corte Internazionale di Giustizia ha confermato che l’ICCPR è applicabile nei confronti di atti compiuti da uno Stato nell’esercizio della sua giurisdizione fuori del suo territorio. La Corte ha osservato che, “se è vero che la giurisdizione degli Stati è primariamente territoriale, essa può talvolta essere esercitata fuori del territorio nazionale. Considerando l’oggetto e lo scopo del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, sembrerebbe naturale che, anche in questo caso, gli Stati parte del Patto dovrebbero essere vincolati a rispettare le sue disposizioni”. Analogamente, il Comitato contro la tortura ha affermato che l’obbligo di non-refoulement contenuto nell’art. 3 della Convenzione contro la tortura si applica in ogni territorio sotto la giurisdizione di uno Stato parte. Anche la Corte europea dei diritti umani ha esaminato il concetto di “giurisdizione” in una serie di decisioni e ha coerentemente sostenuto che il criterio decisivo non è se una persona si trovi all’interno del territorio dello Stato interessato, ma se, rispetto al presunto comportamento, egli o ella si trovi o meno sotto l’effettivo controllo dello Stato, o sia colpito da coloro che agiscono per conto dello Stato in questione. La competenza giurisdizionale di uno stato può essere estesa extraterritorialmente se questo, “attraverso l’effettivo controllo del territorio in questione e dei suoi abitanti all’estero come conseguenza di occupazione militare o attraverso il consenso, l’invito o l’acquiescenza del governo di quel territorio, esercita tutti o parte dei pubblici poteri che di norma sono esercitati da quel governo”. Una situazione nella quale una persona è portata sotto “l’effettivo controllo” delle autorità di uno Stato se esse stanno esercitando la loro autorità fuori del territorio dello Stato, potrebbe inoltre dar luogo all’applicazione extraterritoriale degli obblighi della Convenzione.
Rilevante ai fini del presente contesto è anche la sentenza della Corte europea dei diritti umani in Issa and Ors v. Turkey, dove si conferma che: “Uno Stato può essere considerato responsabile di violazioni dei diritti e delle libertà contenute nella Convenzione di persone che si trovano nel territorio di un altro Stato, ma che si trovano sotto l’autorità e il controllo del primo Stato attraverso l’azione di suoi agenti – sia essa legale o non legale – nel secondo Stato […]. In tali situazioni la responsabilità deriva dal fatto che l’art. 1 della Convenzione non può essere interpretato in modo da consentire a uno Stato parte di perpetrare violazioni della Convenzione sul territorio di un altro Stato, che non potrebbe perpetrare sul suo territorio […]”.
Conclusioni Un’interpretazione che restringesse l’ambito di applicazione dell’art. 33(1) della Convenzione del 1951 a comportamenti che si verificano dentro il territorio di uno Stato parte della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 sarebbe contraria ai termini della disposizione, come pure all’oggetto e allo scopo del trattato in corso di interpretazione, ma sarebbe anche incoerente con le norme di diritto internazionale dei diritti umani pertinenti. L’UNHCR ritiene quindi che uno Stato sia vincolato dal suo obbligo derivante dall’art. 33(1) della Convenzione del 1951 di non rinviare rifugiati verso un rischio di persecuzione ovunque esso eserciti la propria effettiva giurisdizione. Così come per gli obblighi di non-refoulement in base al diritto internazionale dei diritti umani, il criterio decisivo non è se tali persone si trovano nel territorio dello Stato, quanto piuttosto se esse si trovano sotto il suo effettivo controllo e autorità.
Gli accordi italo - libici La politica italiana di respingimento è stata istituita in seguito alla stipulazione del “Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista” del 30 agosto 2008. Il Patto d’amicizia prevede una “intensificazione” della cooperazione nella “lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti e all’immigrazione clandestina”. Le due parti hanno concordato di rafforzare il sistema di controllo di frontiera per i confini di terra libici (con finanziamenti italiani al 50% ed un rimanente 50% da reperirsi attraverso l’Ue), e di avvalersi di società italiane a questo scopo. Il 6 maggio 2009 l’Italia ha cominciato ad intercettare unilateralmente migranti in alto mare su barconi, rinviandoli sommariamente in Libia. Una settimana dopo, Libia e Italia hanno annunciato l’avvio di pattugliamenti navali congiunti nelle acque territoriali libiche, nonostante non fossero chiare le modalità di funzionamento. È previsto che la missione di pattugliamento congiunta tra Italia e Libia avrà una durata iniziale di tre anni. Nella prima settimana dall’inizio del programma di intercettamento, circa 500 migranti sono stati rinviati sommariamente in Libia provocando una drastica riduzione del numero di barconi che si apprestavano a tentare il viaggio dalla Libia. Nel corso delle otto settimane successive, solo 400 migranti sono stati intercettati e rinviati.
La visione italiana dell'intercettamento Il primo ministro italiano, Silvio Berlusconi, ha affermato che “L’idea della sinistra è quella di un’Italia multietnica. La nostra idea non è così”(‘Sì ai rimpatri, non apriremo le porte a tutti’”, Corriere della Sera, 9 maggio 2009 ). Nella stessa occasione ha aggiunto: “Noi vogliamo un'Italia che non diventi un paese plurietnico, pluriculturale, siamo fieri della nostra cultura e delle nostre tradizioni.” Al dichiarare di non aderire all’idea che l’Italia fosse o dovesse essere uno stato multietnico, il primo ministro Berlusconi ha riconosciuto un’eccezione per i rifugiati a rischio di persecuzione. Tuttavia, tale eccezione veniva considerata solo come un’eventualità remota poiché secondo l'opinione del governo italiano “Su questi barconi, come dicono le statistiche, persone che hanno il diritto d’asilo non ce ne è praticamente nessuna. Solo casi eccezionalissimi”. Di fatto, il 75 percento di coloro che sono arrivati in Italia via mare ha fatto richiesta d’asilo nel 2008, e al 50 percento di questi è stata concessa qualche forma di protezione. Secondo il governo italiano, l'obbligo “è di accogliere solo quei cittadini che sono nelle condizioni per chiedere l’asilo politico e che dobbiamo accogliere qui come dicono gli accordi e i trattati internazionali” e cioè “coloro che mettono piede sul nostro suolo, intendendo come piede sul nostro suolo anche le entrate nelle acque territoriali”.
La Convenzione sui Rifugiati del 1951, di cui l’Italia è stato parte, stabilisce che uno stato contraente non possa respingere “in nessun modo” un individuo verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad una determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche. La nozione per cui l’Italia possa inviare la Marina o la guardia costiera in alto mare, per impedire l’entrata dei potenziali rifugiati e rinviarli con la forza, capovolge il senso della Convenzione sui Rifugiati. L'obiettivo di quest'ultima è quello di proteggere i rifugiati dal respingimento verso la persecuzione. La Convenzione non distingue (né affronta il problema) da dove vengano respinti i rifugiati. A destare preoccupazione è dove essi vengano respinti. Il governo italiano sostiene che l’obbligo di non-refoulement non si applichi in alto mare. L’UNHCR ha chiarito che il principio di non-refoulement si applica ovunque uno stato eserciti controllo o giurisdizione, anche in alto mare o nel territorio di un altro stato.
L’outsourcing della politica di migrazione e asilo dell’Ue Il 27 maggio 2009, dopo l’inaugurazione delle operazioni navali congiunte italo-libiche, il vicepresidente della Commissione europea per la Giustizia Barrot ha inviato una lettera al presidente del Consiglio europeo sollecitando un approccio comunitario su asilo e protezione umanitaria. Sul fronte interno, suggeriva uno “sforzo volontario” tra gli stati membri dell’Unione per una “risistemazione di persone sotto protezione internazionale.” Sul fronte esterno proponeva invece la costituzione di relazioni tra l’UNHCR e la Libia, in previsione della creazione in Libia di un piano per la ricezione e la protezione di richiedenti asilo che soddisfi i più alti standard internazionali. In particolare, il piano renderebbe possibile la determinazione dello status degli individui rinviati in Libia, ai quali potrebbe essere poi offerta una risistemazione. In una fase in cui l’UNHCR, il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa, nonché diverse Ong, criticavano l’Italia per la violazioni di norme di diritto internazionale e degli standard europei, neanche uno stato membro dell’Ue criticava pubblicamente l’Italia . Barrot ha finito per esprimere preoccupazione per i respingimenti, dicendo che non erano “la risposta” ed indicando che “i soccorritori, compresa Frontex, possono salvare ma non possono negare l’entrata.” Ma la sua proposta ripropone l'idea dell'esternalizzazione delle procedure dell’Ue per i rifugiati che prevede la sostituzione, con un piano volontario e discrezionale, di standard e procedure d’asilo legalmente applicabili sul suolo europeo.
Il ruolo di Frontex Nell’ottobre 2005 è divenuta operativa l'Agenzia Frontex per la tutela dei confini esterni. Frontex ha lavorato attivamente per arginare il flusso di barconi di irregolari provenienti dall’Africa e diretti verso l’Ue tramite il coordinamento dei suoi stati membri Con il sostegno di Frontex, gli arrivi dei barconi di irregolari nelle isole Canarie, al largo della costa dell’Africa occidentale, sono scesi del 74% dal 2006 al 2008. Nello stesso periodo in Italia gli arrivi su barconi sono saliti del 64%. Nel 2008, al largo della costa africana nordoccidentale, Frontex ha portato ufficiali mauritani e senegalesi a bordo di navi degli stati membri dell’Ue nel contesto dell’operazione “Hera”, la quale, nel corso di quell’anno, ha deviato 5.965 migranti indietro verso la costa africana. Frontex sostiene che le deviazioni erano responsabilità dei funzionari mauritani e senegalesi a bordo delle navi. Nel 2008, l’operazione “Nautilus” si è concentrata sul flusso migratorio tra il Nord Africa e l’Italia e Malta ma non ha deviato alcun barcone indietro verso il Nord Africa. Tale fallimento veniva attribuito alle “differenze di opinione riguardanti la responsabilità dei migranti salvati in mare.” Nel 2009, la fase successiva dell’operazione “Nautilus” fu rimandata perché Malta e Italia non erano in grado di mettersi d’accordo su quale Paese fosse responsabile dello sbarco delle persone salvate in mare.
Il 18 giugno 2009, per la prima volta nella sua storia, un’operazione di Frontex ha portato all’intercettamento e respingimento verso la Libia di un barcone con 75 migranti nel Mediterraneo centrale. Il vicedirettore di Frontex, Gil Arias-Fernandez, si è pronunciato a favore di questa e altre operazioni affini: “Stando alle nostre statistiche, siamo in grado di dire che gli accordi [tra la Libia e l’Italia] hanno avuto un impatto positivo. A livello umanitario, meno vite sono state messe a repentaglio, per via di un minor numero di partenze. Ma la nostra agenzia non ha la capacità di confermare se il diritto d’asilo, così come altri diritti umani, venga rispettato in Libia.” Al di là del problema, evidente, di dire che una politica di rinvio ha avuto un impatto positivo senza sapere se i diritti umani dei respinti siano stati violati o meno, Arias-Fernandez esprime la nozione, scorretta, secondo cui un potenziale vantaggio umanitario (impedire perdite umane in mare) prevalga su un diritto umano (il diritto di partire e il diritto di cercare asilo).
La questione dei rifugiati in Libia La Libia non ha una legislazione interna o procedure disciplinanti l’asilo politico. Sebbene la Libia sia uno stato parte della Convenzione sui Rifugiati del 1969 dell’Oau, che sposa il diritto d’asilo, ed abbia adottato la Carta Africana dei diritti dell’uomo e dei popoli del 1981 che stabilisce che tutti i popoli “hanno diritto, se perseguitati, di cercare ed ottenere asilo in altri Paesi,” non ha, fino ad ora, stabilito alcun meccanismo formale per la protezione di individui in fuga da persecuzioni. Il generale di brigata Mohamed Bashir Al Shabbani, direttore dell’ufficio immigrazione, ha dichiarato ad Human Rights Watch che “non ci sono rifugiati in Libia. Ci sono individui che si intrufolano illegalmente nel Paese e non possono essere descritti come rifugiati. Chiunque entri nel Paese senza documenti e permessi formali viene arrestato.” Il leader libico Muammar Gheddafi, ha definito la questione come una “menzogna diffusa”. Nella sua prima visita in Italia l’11 giugno 2009, ha detto: “Pensiamo davvero che milioni di persone siano in cerca d’asilo? È una cosa che fa davvero ridere”. Ha definito i migranti africani come persone che “vivono nel deserto, nelle foreste, privi di qualunque identità, tanto meno politica. Credono che il Nord abbia tutta la ricchezza, i soldi, per cui tentano di raggiungerlo.” Prima di recarsi in Italia nel luglio 2009, Gheddafi rispose alla domanda se si potesse concedere asilo ai migranti respinti in Libia dall’Italia. Rispose, “Non è assolutamente una questione d’asilo. L’asilo riguarda un numero ristretto di individui per motivazioni politiche, oppure dopo una guerra o dopo disastri naturali. Qui, invece, siamo di fronte ad ondate di immigrazione che si susseguono verso l’ Europa a causa della povertà imperante in Africa.”
La costituzione della Libia del 1969 afferma che “l’estradizione dei rifugiati politici è proibita.” Inoltre, la legge 20 del 1991, “Sull’Accrescimento della Libertà”, afferma che “la Giamahiria sostiene gli oppressi e (...) non deve abbandonare i rifugiati e rinunciare alla loro protezione.” La Libia non ha firmato né la Convenzione sui Rifugiati del 1951 né, tanto meno, il suo Protocollo del 1967, ma sia la Convenzione contro la Tortura che la Convenzione africana sui rifugiati le vietano di inviare individui in Paesi dove corrono un serio rischio di persecuzione o tortura. La Libia è anche uno stato parte del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (Pidcp) il quale, all’articolo 13, proibisce l’espulsione arbitraria e dà agli stranieri diritto ad una decisione individuale sul loro allontanamento o espulsione. Il Comitato per i Diritti Umani ha interpretato l’articolo 7 del Pidcp come un divieto di refoulement di individui verso posti dove corrono il rischio di trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti.